La distribuzione topografica delle evidenze (Tav. IV)
Chiare e organiche evidenze strutturali per unità di abitazione e produzione del periodo Verde sono state messe in luce dei vecchi scavi soprattutto nel cd. “quartiere meridionale” (scavi Inglieri 1932-1993 e Sestieri 1933-1934) [1] ma anche in quello “occidentale” (scavi Griffo 1935-1936) [2]. In entrambe queste aree, l’erosione dei livelli riferibili ai periodi Rosso e Giallo, hanno esposto ampi settori riferibili a questo periodo, pur con evidenti tracce di persistenze del periodo successivo.
Tratti murari riferiti da Bernabò Brea a strutture del periodo Verde sono state messe in luce anche al centro del sito, nell’isolato VII [3], e nel settore settentrionale, in corrispondenza degli isolati IV e V (scavi Pietrogrande 1932 [4]) ma i livelli superiori e affioranti di questi ultimi isolati appartengono piuttosto al periodo Rosso, come dimostrato dai nuovi scavi. Fasi pregresse del Verde sono state individuate dal saggio in profondità di Bernabò Brea nel megaron 832 (cd. “IV megaron”) [5] e nel megaron 317; al periodo Verde appartiene certamente la prima fase del megaron 326 rivelato dai nuovi scavi nel Saggio H/est [6].
A questo orizzonte può essere attribuita, secondo noi, anche la cortina muraria più esterna nel settore meridionale del sito (tratti 3 e 8), mentre già Bernabò Brea riconosceva la pertinenza ai periodi Verde e Rosso della III e IV cortina dell’espansione occidentale (tratti 32-55).
Il rinvenimento di un poderoso sistema a cassone di questa fase (muri G/U) nel Saggio H/est dei nuovi scavi e il probabile collegamento di questa struttura con quelle documentate per il periodo successivo in H/ovest hanno consentito di estendere le conoscenze sui limiti dell’insediamento Verde e Rosso anche verso Nord. Rimane del tutto ignoto, quindi, solo il quadrante NW del sito e il collegamento tra le mura occidentali e quelle settentrionali.
L’assetto complessivo dell’abitato e la sua estensione sono, a partire da questa fase ricostruibili con buona approssimazione, come vedremo analizzandone le principali componenti.
Le mura (Fig. IV.5.1)

La tecnologia più volte osservata nella costruzione degli edifici che si datano al periodo Verde e che ricorre anche nella costruzione delle mura, è rappresentata da un’accurata sovrapposizione di corsi di lastrine piane a spacco in calcare. Questa tecnica costruttiva prevede la realizzazione di corsi di lastre alternate a blocchi quadrangolari (Fig. IV.5.2).

In alcuni tratti sono conservate, al colmo di mura di cinta, alcune lastre litiche di notevole lunghezza, che sembrano aver costituito una sorta di coronamento delle mura o di base per l’ulteriore spiccato delle murature pertinenti alle case, che a queste mura sistematicamente si sovrappongono.
La metodologia strutturale impiegata per realizzare le mura è la stessa del periodo Azzurro, ovvero il caratteristico sistema “a cassoni”, con doppio paramento di pietre e riempimento di terra e setti di collegamento, che rappresenta fin dall’inizio la cifra caratteristica delle mura perimetrali di Poliochni e che segnala con chiarezza la loro funzione primaria di opere di terrazzamento.
Una delle principali novità emerse dai nuovi scavi e dalla nuova sequenza crono-tipologica della ceramica è rappresentata dall’attribuzione al periodo Verde iniziale e non più all’Azzurro evoluto delle cd. “discariche” [7]. Con questo termine tradizionalmente ci si riferisce agli ampi strati di terreno incoerente addossati alla cinta del periodo Azzurro evoluto, sia lungo il tratto SW messo in luce dai vecchi scavi, sia lungo quello settentrionale messo in luce dal Saggio H/est.
La netta distinzione cronologica tra le più antiche mura e le rispettive discariche ha permesso di chiarire come si tratti di due sistemi non sincroni e non complementari in senso funzionale, come si riteneva in precedenza [8]. Questa nuova e diversa interpretazione della discarica contrasta con quanto affermato da Bernabò Brea, secondo il quale “la cinta urbica era stata appena costruita e già incominciava a formarsi al suo piede un interramento che in un tempo relativamente breve doveva giungere a seppellirla fino al suo culmine conservato [9]” ed essa presto “scomparve sotto un enorme scarico di detriti che venne via via interrandola” [10].
Le mura del periodo Azzurro sono, invece, rimaste del tutto libere frontalmente per l’intero loro ciclo funzionale, come anche un’altra serie di indizi strutturali rivela chiaramente (in particolare la presenza di finestrelle drenanti e di porte) [11]. Come ha dimostrato il Saggio A, collocato a ridosso del muro esterno del vano 14, queste mura sono crollate a seguito di un catastrofico evento sismico, che ha provocato la formazione, nello spazio vuoto antistante, di uno stato a pietrame, corrispondente al paramento esterno della struttura a cassone e, al di sopra, di stati terrosi pulverulenti, corrispondenti al retrostante enplecton (contenente ovviamente materiali del periodo Azzurro).
La regolarizzazione di questo crollo, con l’eventuale riporto di ulteriore terreno alloctono (come certamente è avvenuto nell’area Nord) o il mero riutilizzo di quello riversatosi fuori dall’enplecton (come nei settori sud-occidentali), è un’operazione condotta nel periodo Verde, come indicano i materiali dei livelli superficiali di entrambe le discariche. Su questi livelli di regolarizzazione, riporto e colmata viene eretta la nuova cortina muraria del periodo Verde, utilizzando la medesima tecnica a cassoni, ma di maggiore ampiezza in relazione alle mutate esigenze insediamentali. La presenza di strati di discarica rappresenta, quindi, un utile indicatore di possibili mura nel periodo Verde anche laddove queste mura non siano più conservate o la loro nuova indagine sia preclusa.
Di questa seconda e più esterna cortina muraria, costruita con lo stesso sistema a doppio paramento ed enplecton, ma utilizzando i precedenti muri interni (non crollati o solo parzialmente crollati grazie al terreno che li fronteggiava) restano chiare tracce anche nel settore meridionale del sito, escluso da ogni ulteriore indagine dal pericolo di mine.
I tratti indicati nella planimetria generale di Bernabò Brea [12] come 3 e 6-7-8 (Tav. IV) rappresentano con ogni evidenza un rifascio quasi parallelo della retrostante cortina del periodo Azzurro evoluto e non, come ipotizzato da Bernabò Brea, il paramento esterno della cortina del periodo Azzurro [13].
L’attribuzione al periodo Verde della seconda cortina in questi settori è suggerita anche dalla probabile attribuzione allo stesso periodo delle case che a questa estensione si sovrappongono (vani 1151, 1152, 1157, 1158), secondo quella che è la dinamica tipica dell’espansione urbana del sito nei periodi Verde e Rosso. L’avanzamento del fronte murario presuppone, infatti, in tutti i casi documentati dai vecchi (scavi Monaco e Griffo) e nuovi (Saggio H/est) scavi, l’attivazione di nuovi quartieri o l’ampliamento dei vecchi, con l’impostazione di strutture abitative e produttive sulle cassonature murarie pregresse.
Questo rifascio doveva certamente interessare anche i successivi tratti 9-10-12-15 della cortina del Periodo Azzurro come rivelato dal Saggio X in corrispondenza del tratto 10 e dal Saggio A in corrispondenza del tratto 12.
Il primo di questi saggi [14] ha indagato stratigraficamente l’area della cd. “postierla”, evidenziandone la funzionalità di accesso alla città nel periodo Azzurro e la sua obliterazione nel periodo Verde, quando a questo tratto si addossano strati di discarica. Le ampie manomissioni compiute con le impressionanti trincee degli scavi Della Seta, finalizzate ad individuare le mura più antiche, hanno impedito la conservazione delle mura del periodo Verde lungo questo tratto 12, ma ad esse può essere riferito il lungo muro 1169. Esso non è più visibile essendo stato asportato dai vecchi scavi ma è ben documentato nella documentazione fotografica dell’epoca (Fig. IV.5.3), che mostra con chiarezza la sua sovrapposizione a potenti strati di discarica [15].

La porta 11 del periodo Azzurro è sostituita in questa fase dal varco che immette nella strada 130 e che appare risparmiato dalla nuova cortina, conformata a curva nel tratto 6 proprio in corrispondenza del bordo occidentale della strada 130. Il possibile pendant orientale di questo varco nella cortina in corrispondenza della strada 130 potrebbe individuarsi nell’anomalo inspessimento angolare del muro 1164 e in alcuni lacerti della struttura 1165.
Proseguendo verso Nord, non è stata rinvenuta traccia nel Saggio A del muro che nel periodo Verde doveva costituire il corrispondente del paramento esterno del tratto 15 (Bouleuterion), probabilmente ancora a causa delle manomissioni compiute dai vecchi scavi e da un precario stato di conservazione già in antico. In compenso questo saggio ha restituito chiari indizi per la ricostruzione delle dinamiche di crollo della cortina del periodo Azzurro e del retrostante enplecton e ha permesso di datare con certezza al periodo Verde i conseguenti episodi di fruizione superficiale della cd. “discarica”. Dal Saggio A sono stati documentati anche i restauri nel periodo Verde del paramento esterno del Bouleuterion, che in quest’epoca doveva costituire il paramento interno del nuovo cassone murario. Questi rifacimenti comprendono anche la sistemazione con terminazione a sperone dell’angolo NW del cassone 14 – la struttura individuata come muro 16 nella planimetria generale di Poliochni I – andando a formare con il corrispondente muro 23 i propilei della nuova (?) rampa 102a. Alla terminazione 23 doveva collegarsi un tratto curvilineo di cortina, retrostante il rifascio del periodo Rosso (e poi Giallo) 32 e collegata con il tratto 33.
L’attribuzione al medesimo periodo Verde della sistemazione a lastre di questo accesso alla cittadella, certamente uno dei principali, è stata accertata con il Saggio C [16]. Almeno a partire da questo orizzonte Verde, la rampa 102a inizia, quindi, a svolgere la sua funzione di importante accesso carrabile alla cittadella, ed è ora strutturata con due contrafforti verso l’esterno, che costituivano anche i terminali dei paramenti esterni della nuova cortina muraria.
Oltre la rampa 102a e il tratto di cortina 32 la rilettura delle tracce residue della cortina del periodo Verde e delle sue riprese nel Periodo Rosso coincide sostanzialmente con quella già proposta da Bernabò Brea. L’ampia estensione coincidente con lo scavo Monaco 1933-34 ha comportato il ripristino del paramento orientale (30) del vano 28 (Granaio), la regolarizzazione della discarica (con probabile ulteriore riporto di terreno per livellare) e l’impostazione del nuovo paramento orientale rappresentato dai tratti di cortina del periodo Verde (e poi Rosso) 33a-b-c. Sempre al periodo Verde (e non Rosso come pensava Bernabò Brea), come indica chiaramente la regolare tecnica a blocchetti e lastre, appartiene il rifascio (?) 36-37 e l’aggetto 35. Su questa estensione si impostano le case del periodo Verde individuate da Bernabò Brea nei muri 805 e 809.
Il collegamento di questi tratti 35-37 ai tratti 45 e 48 è evidente dalla planimetria e non doveva prevedere in questa fase, né nella successiva Rossa, alcun varco in corrispondenza della scaletta 38 e della strada 121, trattandosi di superfetazioni posteriori (del periodo Giallo), come tutto lo sperone addossato 39-40 [17].
Al di sotto del potente rifascio del periodo Rosso 49, la prosecuzione della cortina esterna del periodo Verde è facilmente individuabile nel collegamento del tratto 48 con i tratti 49-50-53 e 54, mentre molto dubbia resta la prosecuzione con il breve e del tutto residuale tratto angolare 55. Questa ulteriore estensione del percorso, con una sorta di grande sperone, coincide con il quartiere Verde e Rosso scavato da Griffo nel 1935-36. La sovrapposizione a questo grande terrazzamento artificiale di case già nel periodo Verde è ben documentata dagli scavi, così come il possibile varco individuato dalla soglia 51 e dall’imboccatura 52 nella strada 120. Questo “spazio trapezoidale”, come era stato definito dai vecchi scavatori, costituisce forse il miglior esempio di come dovevano funzionare i varchi alla cittadella, conformati a rampa lastricata tra due muri convergenti di delimitazione degli opposti cassoni.
Con il tratto 54 si interrompono le nostre conoscenze sul percorso della cortina del periodo Verde (e Rosso) nel settore sud-occidentali dell’insediamento.
Il collegamento con le evidenze risultanti dai nuovi scavi nel settore settentrionale (H/ovest) è del tutto ipotetico, non potendo fare affidamento neppure su una mera logica di adeguamento a quote uniformi del terreno su cui queste murature dovevano fondarsi: intorno a 11 m s.l.m. i tratti dell’ampliamento occidentale, intorno a 16 m s.l.m. quelli dell’ampliamento settentrionale. Il tratto di collegamento doveva, quindi, risalire questa differenza di quota con un percorso che possiamo ricostruire solo in modo generico. Solo il completamento degli scavi nell’intero settore nord-occidentale, del tutto inesplorato, potrebbe consentire di ricostruire con precisione il tratto delle mura dei periodi Verde e Rosso su questo versante. Nella ricostruzione planimetrica in Fig. IV.5.1 questo collegamento tra il settore sud-occidentale e quello nord-orientale è stato ipotizzato come simmetrico a quello noto ma il margine di incertezza è troppo ampio per considerarlo più che meramente indicativo della possibile estensione (massima) del sito in queste fasi.
Nel settore nord-orientale, oggetto delle nuove indagini, il primo tratto di cortina esterna riferibile alle fasi intermedie del sito è rappresentato dal grande muro a ciottoloni che percorre il ciglio occidentale della cd. “acropoli”, ovvero la parte più alta dell’insediamento, a quota 16 m s.l.m. Conservato su un unico filare di grossi e irregolari ciottoloni e poggiante direttamente su strati di “discarica”, questo muro appare tecnologicamente riferibile al periodo Rosso. È possibile che questo muro ricalchi, come nei tratti noti, un precedente percorso già del periodo Verde, che non è stato messo in luce dal Saggio H/ovest, limitato in questi settori ad una pulizia superficiale [18].
Questo muro si collega chiaramente con una sorta di torre quadrangolare del medesimo periodo Rosso, realizzata nella stessa tecnica a grandi ciottoloni e poggiante anch’essa su livelli di discarica, che probabilmente ne rappresenta la terminazione settentrionale (Fig. IV.5.4). Muro e torre sembrano individuare, quindi, la terminazione angolare nord-occidentale dell’espansione settentrionale dell’insediamento, messa in opera nel periodo Verde e risistemata nel periodo Rosso.

La terminazione orientale di questa espansione è rappresentata dal sistema a cassone del muro G e annessi, messo in luce dal Saggio H/est. Il collegamento tra questi sistemi (muro/torre e cassone) non è più riconoscibile a causa degli sconvolgimenti operati nell’area dello scavo Arias, ma il grande muro visibile nella sezione meridionale di questi scavi (Fig. IV.5.5) potrebbe rappresentare un indizio del braccio settentrionale dell’espansione in parola. Come dimostrato dai diversi approfondimenti del Saggio H/est si tratta di una grandiosa opera di terrazzamento artificiale realizzata nel periodo Verde e anche qui addossata al paramento della cortina muraria del periodo Azzurro evoluto (S).
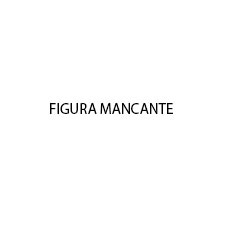
L’impianto di strutture del periodo Verde (come la fase I del megaron 301 e annessi) fissa anche in questi settori la cronologia di fruizione di questa espansione, così come allo stesso periodo Verde si datano i materiali più tardi contenuti anche in questa “discarica Nord” [19].
L’espansione settentrionale documentata da queste strutture comprende una superficie complessiva di ca. 900 mq. Restano escluse da questa estensione le strutture individuate dagli scavi Arias ancora più a Nord e attribuite dal ricontrollo stratigrafico effettuato con il Saggio T al periodo Verde [20]. La notevole irregolarità della loro planimetria rispetto agli standard di questo periodo suggerisce una loro funzione non residenziale, forse come ovili o comunque ambienti destinati ad altre produzioni (pirotecnologiche?), che richiedevano una collocazione esterna al circuito murario.
La prosecuzione del circuito murario lungo il ciglio costiero è stata accertata con il Saggio M, che presenta chiare evidenze strutturali e stratigrafiche di rifacimenti nel periodo Verde del sistema a doppio paramento con enplecton, fronteggiato da setti, eretto inizialmente nel periodo Azzurro evoluto [21]. Queste evidenze consentono di ipotizzare anche nel periodo Verde un sistema di consolidamento e terrazzamento del ciglio costiero, su cui correva una stradella parallela al “cardo” 105 e su cui si impostarono case dei periodi Verde e Rosso.
Il collegamento, verso Nord, tra questo tratto di mura marittime nel Saggio M e il paramento esterno del sistema a cassone G/U nel Saggio H/est è segnalato da un tratto residuo di questa cortina, lungo lo stesso ciglio costiero all’altezza del megaron 317 (Fig. IV.5.6). La cronologia esatta di queste mura non è stata accertata da saggi ma la loro pertinenza a sistemi di terrazzamento verso mare nei periodi Azzurro e Verde è reso evidente, oltre che dalla posizione e l’assetto dei paramenti esterni, anche dalla tecnica a lastre regolari, tipica delle murature del periodo Verde.
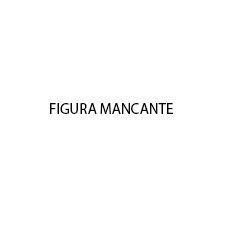
Verso Sud non sono disponibili ulteriori finestre di visibilità per strutture murarie lungo il ciglio costiero ma è possibile ipotizzare che il loro percorso ne seguisse regolarmente il profilo collegandosi con il tratto 3 e saldando così il perimetro completo della cittadella.
Nel periodo Verde la funzione difensiva delle mura, complementare a quella fondamentale di terrazzamento e consolidamento dell’abitato, appare confermata dal rinvenimento di una punta di freccia in bronzo nell’ambiente messo in luce dal Saggio X a ridosso dell’occlusione della porta 10. È del tutto probabile, però, che le funzioni complementari di terrazzamento/sostruzione e recinzione/difesa fossero preordinate già alla prima costruzione delle mura nel periodo Azzurro evoluto.
L’organizzazione dell’abitato
A partire dal periodo Verde possono riconoscersi tracce evidenti e ben strutturate dell’organizzazione dello spazio urbano interno al circuito murario. A questo periodo e al successivo periodo Rosso possono riferirsi con un buon grado di approssimazione assi viari principali e secondari, che preesistono e condizionano anche la facies superficiale del periodo Giallo. Nella Tav. IV è rappresentata una possibile interpretazione dell’organizzazione urbana di Poliochni nei periodi Verde e Rosso, che tiene conto delle strade individuate dai vecchi e nuovi scavi e del relativo assetto degli isolati, ma non è possibile distinguere con ulteriore chiarezza le sottofasi di questa organizzazione, che potrebbe in parte confondersi anche con quella del successivo periodo Giallo.
L’assetto fondamentale dell’insediamento, con isolati di forma tendenzialmente quadrangolare separati tra loro da un reticolo viario incentrato sulle due piazze 103 e 106 e il “cardo” di collegamento rappresentato dalla strada 105, appare comunque chiaro fin da questa fase e permarrà sostanzialmente fino all’epilogo della frequentazione nell’antica età del Bronzo.
Lo schema planimetrico che emerge dalla Tav. IV evidenzia una struttura tendenzialmente reticolare, se non quasi-ortogonale, del tracciato viario, che incrocia assi longitudinali con percorrenza N-S ad assi latitudinali con percorrenza E-W. Adattamenti morfologici, al profilo della collina e strutturali, ai limiti perimetrali fissati dalle mura e alle progressive superfetazioni murarie, condizionano ovviamente questa tendenziale regolarità dell’impianto, di cui le piazze 103 e 106 rappresentano i fulcri e i centri generatori.
La piazza 103 è direttamente collegata dalla strada 102 all’ingresso principale della città. La sua attuale conformazione “ a clessidra”, composta da due slarghi (103a-103 b) separati da una strettoia, è il risultato delle espansioni di tipo squatting dell’ultima fase del periodo Giallo, quando gli isolati VIII e IX ne invadono i lati orientale e settentrionale con irregolari vani curvilinei e con la grande canaletta scoperta di drenaggio. Nella fase Verde e probabilmente già Azzurra questa piazza aveva, invece, forma regolarmente rettangolare, delimitata dai fronti originali degli isolati VIII, IX, XX e probabilmente anche XXVI (non scavato) e copriva una superficie complessiva di ca. 200 mq.
Una regolare pavimentazione a lastre interessava in origine l’intera ampiezza della piazza ed era interrotta, nell’angolo NW, dall’apertura pentagonale connessa da enormi lastroni di un pozzo a canna cilindrica, probabilmente già attivo in queste fasi [22]. La collocazione strategica per i rapporti esterni del nucleo abitativo e le ampie dimensioni sembrano effettivamente qualificare questa piazza – seguendo Bernabò Brea [23] – come la “agorà commerciale” della cittadella.
Anche la piazza 106 doveva presentare in origine pianta regolarmene rettangolare, compresa tra gli originali fronti regolari degli isolati IV (zone A-B) e V, composto dall’isolato megaron 317 sul lato settentrionale e da edifici ignoti sul lato NW. Nell’ipotesi di Tav. IV le dimensioni sono di poco inferiori ai 150 mq. La presenza di questa piazza in tutte le fasi dell’insediamento strutturato, cioè a partire dal periodo Azzurro evoluto, è stata documentata dalla trincea di saggio aperta da Bernabò Brea al suo centro. Questo saggio non ha mai incontrato strutture murarie e quindi provato esservi sempre stato uno spazio vuoto [24]. I tagli 9-11 hanno intercettato la pavimentazione della piazza riferibile al periodo Rosso, mentre i tagli 12-13 quella del periodo Verde.
Anche in questo caso, un angolo della piazza (quello SW) è occupato da un pozzo, la cui apertura è sempre circondata da grandi lastroni, ma che presenta canna quadrangolare. Il riempimento è stato completamente svuotato dal Pietrogrande ed è risultato composto da materiali di discarica – probabilmente simultanea a scopo di defunzionalizzazione – pertinenti a varie epoche, ma anche in questo caso è probabile che un pozzo fosse attivo in questo punto fin dalla fondazione della città, nel periodo Azzurro evoluto.
La collocazione ai piedi della cd. “acropoli” e l’affaccio sul suo lato settentrionale dell’edificio con funzioni particolari 317 sembra qualificare questa più piccola piazza come un possibile pendant cerimoniale o comunque riservato ad attività più riservate rispetto a quelle di scambio commerciale svolte dalla piazza 103.
Le due piazze 103 e 106 sono collegate tra loro dalla strada 105 e su di esse convergono una serie di strade divisorie di isolati, con andamento non rettilineo e talora sinuoso, ma chiaramente disposte a raggiera rispetto alla strada 105 e alle sue parallele.
Nella piazza 103 sfociano (Tav. IV), provenendo da Ovest, la strada 102, collegata alla rampa che attraversa la porta principale e la strada 124, che prosegue la strada 123e ha a sua volta inizio dalla strada 122. Questi due assi E-W sono collegati tra loro da due possibili tracciati paralleli: il primo, in prosecuzione del vicolo 105 divideva la parte occidentale da quella orientale dell’isolato IX; il secondo doveva proseguire verso Sud la stradella 122, sovrapponendosi al ciglio esterno delle fortificazioni del periodo Azzurro e dividendo l’isolato IXa dagli isolati X e XI della nuova zona di estensione occidentale.
Ulteriori assi E-W, grossomodo paralleli a 102 e 123-124, sono evidenziati rispettivamente dal collegamento dei tratti 116-117-118 e 113/115 [25], separati dalla piazzetta 114. Da questa piazzetta si dipartono due stradelle (senza nome) con tracciato irregolare verso SE e NE, che dividono le zone A e B rispettivamente degli isolati VII e VI. Quest’ultima stradella, riconoscibile nell’andamento parallelo e sinuoso dei muri del periodo Rosso che la fiancheggiano, sfocia nella piazza 106, a cui giunge anche il tratto residuo di un altro probabile asso E-W, rappresentato dal vicolo 111, che divide l’isolato VI dal V.
Verso Nord non è possibile seguire lo sviluppo della rete viaria e dell’assetto urbanistico dell’insediamento a causa dell’esiguità delle zone indagate con scavi. Le recenti indagini sembrano peraltro escludere una prosecuzione della strada 107 verso Nord [26], mentre la stradella 109 sembra isolare semplicemente il megaron 317 dagli edifici circostanti.
L’ultimo asse E-W verso Nord può essere individuato nella strada 108, che divide l’isolato III dal IV, collegandosi ad Est con un asse N-S parallelo al “cardo” 105. L’esistenza di una strada che percorreva il ciglio costiero, sovrapponendosi alla cortina muraria marittima, è stata evidenziata dai nuovi scavi, sia nel Saggio H/est che nel Saggio M [27], mentre il collegamento tra queste evidenze può essere individuato in prossimità degli spezzoni di murature esterne visibili sulla sezione costiera in corrispondenza del megaron 317 [28].
Nel cd. “quartiere meridionale”, a Sud della strada 102, la complessità del tessuto abitativo, non chiaramente decodificata dai vecchi scavi, si riflette in una situazione meno chiara anche del retico viario. È probabile che il “cardo” 105 proseguisse verso Sud in corrispondenza del possibile tratto residuo rappresentato dalla strada 127, a Est dell’isolato XX, mentre il tratto 128 potrebbe rappresentare una traccia della prosecuzione orientale dell’asse parallelo E-W individuato dalle strade 112 e 125.
Ancora più a Sud, l’irregolarità degli isolati XXIII, XXIV e XXV è evidenziata dai percorsi sinuosi delle strade che li separano: 130-131-132, di cui la prima e l’ultima in collegamento con altrettanti accessi alla città da Sud.
Le strutture di abitazione e produzione
Nel quartiere meridionale, dove le evidenze strutturali del periodo Verde hanno carattere ampiamente estensivo è possibile individuare (almeno) quattro isolati: XXII, XXIII, XXIV e XXV (Tav. IV). In questi blocchi possono riconoscersi planimetrie complessive a carattere ripetitivo, imperniate su blocchi affiancati di megaron/cortile e vani secondari.
L’isolato XXII (cd. “casa meridionale” dello scavo Sestieri 1933-34) è delimitato dai resti della cd. “casa settentrionale” a Nord (isolato XXI) e dal percorso sinuoso della s. 129 a Sud, dalla strada 128 ad Ovest e della strada 127 a Est.
Si tratta di un complesso certamente unitario per quanto le sovrapposizioni nei periodi successivi non consentano di riconoscerne con sicurezza l’intera planimetria. Tre vani allungati paralleli e con analoghe dimensioni (1027, 1028, 1029) occupano l’ala occidentale, mentre quella centrale è occupata da un cortile (1026) su cui si affaccia un ambiente (1025) apparentemente rettangolare (coperto verso Nord da superfetazioni del periodo Rosso e Giallo) e che potrebbe ben essere interpretato come megaron. L’ala orientale doveva essere occupata da piccoli vani quadrangolari di servizio, come l’unico superstite (1022, forse 1023).
Una planimetria a blocchi affiancati con orientamento N-S (vani 1100, 1102, 1103, 1104-5) presenta anche l’isolato XXIII, delimitato verso Sud dalle strade 131 e 129, scavato solo parzialmente verso Ovest e coperto da resti dei periodi Rosso e Giallo verso Nord. La lettura planimetrica di questo isolato è complicata dalle cospicue sovrapposizioni strutturali, con evidenti modifiche già nel periodo Verde e dal fatto che le strutture indagate sono pertinenti a livelli di fondazione e non aerei, come dimostrato dal mancato reperimento delle soglie e dei piani pavimentali.
Una chiara articolazione tripartita con assi N-S è restituita dall’isolato XXIV (“casa occidentale” dello scavo Inglieri), anch’esso strutturato in due fasi e chiaramente delimitato su almeno tre lati dalle stradelle 130, 131 e 132. Al centro la sequenza cortile/megaron è indiziata dal cortile lastricato 1117 e dal vano rettangolare 1116, il cui muro meridionale viene spostato in avanti in seconda fase mentre il rifascio di quello settentrionale invade parte della stradella 131. Le ali laterali sono occupate da tre piccoli vani di servizio 1113, 1114 (unico pavimentato e con pentole infossate e mortaio litico) e da un unico grande vano 1115 ad Ovest, con apertura sul cortile. Due vani irregolari (1119-1120), forse aggiunte seriori, si incuneano verso SE seguendo il corso della strada 132 e forse di un’altra stradella o vicolo cieco in corrispondenza del filo esterno della cortina (obliterata) del periodo Azzurro. Ad essa si sovrappone il piccolo vano quadrangolare 1121, con muri poderosi e spazio interno poco superiore a 1 mq, interpretato da Bernabò Brea come granaio [29].
Il grande agglomerato di edifici delimitato a Nord dalla strada 129 e a Est dalla strada 132, ampiamente sconvolto dalla piccola necropoli medievale del villaggio di Vroskopo, è stato rubricato complessivamente da Bernabò Brea come isolato XXV. Esso appare articolato in almeno tre blocchi distinti da due lunghi e spessi muri, probabilmente perimetrali di isolati, che si incrociano ad angolo verso Est. All’interno di questi muri ad angolo, il blocco centrale (XXVb) appare conformato non in piccole abitazioni distinte di due-tre vani, come pensava Bernabò Brea [30], ma secondo la caratteristica tripartizione di vani in senso N-S dalle serie affiancate di vani 1124-1126 ad Ovest; 1125, 1127 e 1128 al centro (tutti vani di servizio e accessori) e dal cortile 1129 e dal vano sub-megaroide 1130 a Est [31]. Il prolungamento a spina del grosso muro perimetrale settentrionale verso Est divide le stradelle 129 e 132 e crea un ricettacolo ad angolo con il vano 124 per l’alloggiamento di un’interessante ma poco nota struttura da combustione, che potrebbe essere un forno.
Un’altra casa indipendente, ma la cui conformazione generale ci sfugge a causa della parzialità dello scavo, è rappresentata dai vani a Nord del grande muro perimetrale dell’isolato XXVa, denominati XXVb e accessibili da una sorta di slargo lastricato della stradella 129 (1107).
Di non facile lettura è anche il blocco strutturale XXVc a Sud di XXVa, in cui è forse possibile riconoscere la sequenza cortile/megaron nei vani posti ad Ovest 1131 (cortile lastricato) e 1131-1132, mentre verso Ovest la complessità stratigrafica e strutturale e l’incompletezza dello scavo non consente di distinguere tra i possibili vani di servizio.
In sintesi, in questo settore, è parso possibile riconoscere un’articolazione planimetrica tripartita dei singoli isolati più estesamente indagati del periodo Verde con sistematica affiancamento di serie parallele di vani, con orientamento N-S, tra cui si individua quella composta da megaron e cortile, posta in posizione canonica al centro e affiancata da vani di servizio nell’isolato XXII (vani 1125-1126) e nell’isolato XXIV (1116-1117) mentre costretta ad una posizione laterale dalla conformazione triangolare e non quadrangolare dell’isolato XXVa (1129-1130) e probabilmente anche XXVb (1131-1132/3).
Più limitate ma comunque significative evidenze strutturali del periodo Verde sono state rilevate dagli scavi Griffo 1935-36 sul cd. “pendio occidentale” della collina di Poliochni, al di sopra dell’estensione artificiale realizzata nello stesso periodo della cortina muraria perimetrale.
In quest’area le strutture del periodo Verde – conservate su altezze significative (0,8-1,4 m) – sono state messe in luce dal progressivo dilavamento dei livelli del periodo Rosso, a quote notevolmente più basse rispetto a quelle dei retrostanti isolati XV e XVI di quest’ultimo periodo.
La porta urbica 52 con profonda conformazione a tenaglia, che si prolunga nella stradella 120a, separa questi edifici in due blocchi distinti e di diversa forma e dimensioni, corrispondenti agli isolati XVII a Sud e XVIII a Nord.
L’isolato XVII appare decisamente più ampio e conserva una forma sub-quadrangolare o meglio trapezoidale, condizionata da quella della compelssiva estensione terrazzata su cui sorge [32]. L’identificazione del cortile nel vano 857 (e forse anche 856) potrebbe portare a riconoscere una funzione para-megaroide al lungo vano rettangolare con orientamento N-S 859 e a quello affiancato 860, individuando in questi ambienti l’ala orientale dell’isolato, a cui se ne affianca una occidentale, composta dai vani 858, 861, 862 (interessati da una forte erosione che non ha consentito la conservazione dei piani pavimentali).
Nel piccolo isolato XVIII già Bernabò Brea riconosceva un possibile megaron nel grande vano rettangolare 864a (ca. 11 x 6 m), affacciato sul cortiletto scoperto 864b, che avrebbe però orientamento anomalo E-W invece che N-S, come in tutti gli altri casi descritti sopra. A questa serie di vani si affianca il piccolo vano senza porte 865, unico riconoscibile del resto dell’isolato a causa delle ingombranti sovrapposizioni (con orientamenti del tutto diversi) del periodo Rosso.
Edifici con funzioni particolari
L’unico edificio dei periodo Verde e Rosso a cui possano riferirsi funzioni di livello comunitario e non domestico o comunque privato è rappresentato dal megaron 317 (Fig. IV.5.7). Si tratta dell’unico megaron completamente isolato e circondato da una stradella (109) che lo separa dalle strutture limitrofe, peraltro del tutto ignote se non per le tarde fasi del periodo Giallo, alle quali appartiene la cd. “casa absidata” composta dai vani 319-321.

La prima fase di questo megaron, datata al periodo Verde, è nettamente dislocata verso Nord rispetto alle successive e di maggiore ampiezza verso Ovest (largh. interna: 4,20 m; esterna: 5,30 m), mentre non se ne conosce la lunghezza esatta.
La possibile funzione pubblica e, forse, specificamente cultuale di questa struttura appare evidenziata, oltre che dal totale isolamento, anche dalla tecnica particolarmente accurata di costruzione.
La probabile funzione pubblica e forse specificamente cultuale di questa struttura appare evidenziata, oltre che dal totale isolamento e dall’affaccio meridionale sulla piazza 106, anche dalla tecnica particolarmente accurata di costruzione. Ulteriori elementi per una più precisa interpretazione funzionale non sono stati, però, rilevati dai vecchi scavi.
Considerazioni
Tenendo conto delle evidenze strutturali estensive derivanti dai vecchi scavi nei settori meridionale e occidentale della cittadella le modalità abitativa del periodo Verde risultano, quindi, articolate:
- cronologicamente, in due fasi strutturali successive conseguenti ad eventi catastrofici interessanti l’intero insediamento, chiaramente individuate nel saggio in profondità condotto da Bernabò Brea nel megaron 832 ma evidenziate anche dai vecchi scavi negli isolati XIV; XVII-XVIII e XXII-XXV. Queste due fasi strutturali corrispondono al passaggio sul piano tipologico dal periodo Verde iniziale a quello evoluto;
- topograficamente, in complessi edilizi isolati da strade, di forma variabile ma tendenzialmente quadrangolare, occupati da strutture con planimetria di norma tripartita in sequenze di ambienti con assi N-S; tra queste sequenze si riconosce negli isolati meglio noti e completamente indagati (XXII, XXIV, XXVa) la coppia megaron-cortile, collocata in posizione centrale e affiancata da sequenze parallele di vani secondari, di piccole o medie dimensioni con planimetrie rettangolari o quadrate e con probabile funzione di deposito/conservazione e di produzione artigianale e alimentare.
Vincenzo Tiné
Note
[1] Poliochni I, 417-462.
[2] Poliochni I, 385-414.
[3] Poliochni I, 469.
[4] Poliochni I, 243 ss.
[5] Poliochni I, 73 ss.
[6] Cf. supra, II.4 saggio H/est, 000-000.
[7] Cf. supra, IV.3 L’insediamento del periodo Azzurro arcaico, 000-000
[8] Poliochni I, 203.
[9] Poliochni I, 136.
[10] Poliochni I, 117.
[11] Cf. supra, IV.3 L’insediamento del periodo Azzurro arcaico, 000-000
[12] Poliochni I, tavv. 10-12.
[13] Non numerati nella cartografia di Poliochni I perché interpretati unitariamente da Bernabò Brea come struttura a cassone sincrona del periodo Azzurro evoluto.
[14] Cf. supra, II.11 saggio X, 000-000.
[15] Questa evidenza dimostra come le strutture murari del periodo Verde vengano semplicemente sovrapposte alla discarica, esito del crollo della cortina del periodo Azzurro, senza alcuna preoccupazione di regolarizzazione o sgombero.
[16] Cf. supra, II.2 saggio C, 000-000 e III. Tipologia della ceramica, 000-000; v. anche Arkontidou – Tiné – Traverso 1993, 361.
[17] È perciò del tutto improbabile che appartengono al periodo Verde gli spezzoni murari contenuti nel vano 901.
[18] A questo ipotetico muro di cortina del periodo Verde, precedente quello Rosso, era stato attribuito (Tiné V. 1999) una struttura con apparente filo regolare verso Est che ad un ricontrollo effettuato nel 2014 si è rivelato essere allo stesso livello del muro Rosso e composto dagli stessi ciottoloni, per cui sembra interpretabile piuttosto come crollo del medesimo muro.
[19] Cf. supra, II.9 saggio T, 000-000.
[20] Cf. supra, II.9 saggio T, 000-000.
[21] Cf. supra, II.6 saggio M, 000-000 e IV.4 L’insediamento del periodo Azzurro evoluto, 000-000.
[22] Il riempimento non è stato saggiato da Bernabò Brea a causa dell’esser divenuto ricettacolo di pericolosi residuati bellici.
[23] Poliochni II, 25.
[24] Poliochni II, 41 ss.
[25] Questi tratti viari 113 e 115 sono orientati sullo stesso asse delle strade 119 e 120, che dividono rispettivamente gli isolati XIV-XV e XVII-XVIII e conducono alla porta urbica 52.
[26] Cf. supra, II.4 saggio H/est, 000-000.
[27] Cf. supra, II.6 saggio M, 000-000 e II.4 saggio H/est, 000-000.
[28] Cf. supra, 000 e Fig. XXX.
[29] Poliochni I, 446.
[30] Poliochni I, 458 ss.: queste piccole abitazioni sarebbero state composte rispettivamente dai vani 1124 e 1125; 1126, 1127 e 1128 e 1129-1130.
[31] Un’interessante banchina di 1,35 x 0,85 m, che ricorda quelle rinvenute nel vano 326 di H/est, era affiancata al lato W di questo vano e ad essa era sovrapposto un vaso contenitore.
[32] Le strutture di questo isolato sono state rinvenute inserite in un deposito sciolto, cineritizio, con numerosi molluschi e ossa, de tutto analogo a quello caratteristico delle cd. “discariche”, ovvero dei terreni di riporto utilizzati come connettivo delle opere murarie del periodo Verde in tutti i tratti indagati dai vecchi e dai nuovo scavi.
