Il saggio denominato H/ovest è stato realizzato in tre diverse campagne di scavo, rispettivamente negli anni 1993, 1995 e 1997 [1] . L’area prescelta è ubicata presso l’estremità nord-occidentale della collina di Poliochni, in prossimità della scarpata che per i primi scavatori rappresentava il limite settentrionale dell’abitato [2].
Anche in questo caso la finalità del saggio era quella di individuare e indagare eventuali strutture murarie di perimetrazione dell’insediamento in questo settore del sito.
H/ovest 1993
Il saggio è costituito da una trincea di 24 m in senso EW, larga 1,5 m in senso NS e suddivisa in 12 settori indicati con numeri romani da E verso W (Fig. II.5.1, Fig. II.5.2, Fig. II.5.3, Fig. II.5.4). Sul lato orientale inizia ai margini degli ambienti 308 e 309 parzialmente messi in luce negli anni ’30 da Pietrogrande. I primi cinque settori si estendono al limite del ciglio della piccola altura (la cd. “acropoli”) che degrada verso W con un declivio abbastanza marcato; il limite occidentale del XII si arresta a ca. 14 m dalla recinzione dell’area archeologica.
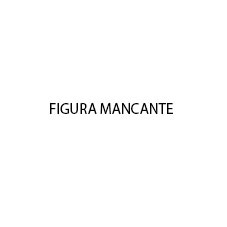
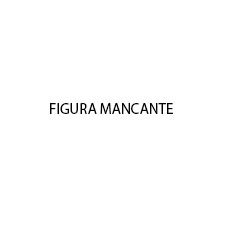
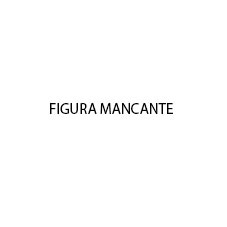
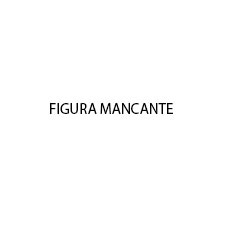
In nessuno dei settori è stato raggiunto il livello di terreno sterile né tanto meno la roccia.Il momento più antico di occupazione dell’area è stato individuato in VII e in IX.
In VII è stato messo in luce un ampio tratto di muro (VII/2) con andamento curvilineo in direzione EW con una piccola anta sul lato meridionale e conservato su 2 filari. Il livello di occupazione della struttura ha restituito un complesso omogeneo di ceramiche assegnabili al periodo Azzurro arcaico. In IX è stato profilato un imponente muro di ca. 70 cm di spessore con andamento alquanto curvilineo che ha restituito anch’esso materiali assegnabili al periodo Azzurro arcaico.
La struttura absidata (VII/2) e il muro IX/2 sono entrambi sigillati da uno strato di terra cineretizia e carboni che sembra rappresentare il momento di distruzione di queste strutture.
Su questo strato di incendio si imposta il muro IX/1 conservato su 3 filari con orientamento NS, che, sia nel livello di crollo che in quello sottostante di frequentazione, ha restituito materiali assegnabili al periodo Azzurro arcaico [3].
Al medesimo momento costruttivo appartengono per ragioni stratigrafiche i muri VII/1, costruito sul livello di costruzione di VII/2, e il muro che si è profilato sotto la struttura del periodo Verde XI/1.
Ad un momento successivo si assegnano la discarica individuata in VI e V e probabilmente anche la prima fondazione del muro V/1, successivamente ripreso nel Verde. La discarica ha restituito materiali inquadrabili tutti nel periodo Azzurro evoluto. Si segnala anche l’ampio tratto di parete e spalla di un’anfora biansata che potrebbe rientrare in quella classe d’importazione definita da Bernabò Brea “ceramica a striature” [4].
Dopo l’abbandono delle strutture del periodo Azzurro, uno spesso strato (35 cm ca.) di terreno limo-argilloso ricco di grumi di calcare e con pochissimi materiali ceramici si deposita sulle strutture più antiche. Questo strato, che costituisce uno hiatus tra l’ultimo momento costruttivo dell’Azzurro e il successivo del Verde, potrebbe essere in rapporto con un fenomeno di carattere alluvionale. Si tratta della cd. “discarica Nord”.
Su questo deposito si impostano le strutture del periodo Verde distribuite in due settori: uno nella parte a valle (IX-XII), rappresentato da 2 ambienti separati da uno stretto spazio aperto e l’altro nella zona a monte (I-II), con l’ambiente 309 (già parzialmente esplorato dal Pietrogrande) e una struttura con fronte a banchine e ingresso delimitato da 2 stipiti che potrebbe trovare un riscontro a livello tipologico e architettonico nel megaron 317.
Sempre al Verde si assegna un ambiente parzialmente messo in luce a W della struttura a banchine, che ha restituito una pentola tripodata collocata in un apposito apprestamento sul piano pavimentale.
Allo stesso periodo, per ragioni stratigrafiche, va assegnato anche il muro a lastre rettangolari (VIII/2) che poggia direttamente sullo strato alluvionale. Al medesimo momento va assegnato anche il rifacimento del muro V/1, che insieme al muro VI/1, probabilmente potrebbero costituire un sistema di contenimento di questa parte della collina.
Ad un momento posteriore al Verde e anteriore all’imponente distesa di pietrame nel Giallo potrebbe essere assegnato il muro VIII/1 con orientamento NE-SW e spessore di 1,50 m, che potrebbe costituire un rafforzamento delle strutture di contenimento del periodo Verde.
Nei settori a monte immediatamente al disopra del crollo delle strutture verdi si dispiega una enorme pietraia che si arresta al limite del dosso, forse perché bloccata dal muro del periodo Verde VI/1, che ha restituito esclusivamente ceramica del periodo Giallo. Resta ancora incerta la natura di questo spargimento di pietre.
H/ovest 1995
L’area di scavo è stata ampliata verso N con l’intento di accertare la prosecuzione di un muro che era parso costituire il limite della cittadella su questo versante (Figg. 5-8).
Esso invece si è rivelato appartenere ad un’abitazione del periodo Verde sovrastante la scarpata che si estende lungo tutto il versante nord-orientale. Una scarpata che, con un tratto affiorante in superficie di muro a grosse pietre, era stata interpretata da Bernabò Brea come i resti di un terrazzamento agricolo di età medievale.
L’ampliamento del saggio ha messo in luce alcune tracce di questo muro, conservate per un solo filare, muro che va datato probabilmente alle fasi tarde di Poliochni (periodo Viola?). Tale datazione sarebbe confermata dal rinvenimento, nel terreno che si addossa a questo muro, di alcuni frammenti ceramici e soprattutto da un paio di frammenti di età micenea trovati durante la pulizia praticata nel settembre 1994 in occasione dei lavori di pulizia e restauro condotti dall’Ephoria per il progetto “Egeo”.
Se questo tardo muro di cinta sovrasta un più antico muro, alle cui rovine sarebbe dovuto il dislivello già notato, non è stato ancora del tutto chiarito. Infatti, tra nel tratto a forte pendenza si intercalano una serie di costruzioni in gran parte attribuibili al periodo Verde che hanno reso impossibile approfondire lo scavo per accertare in maniera inequivocabile la presenza del muro. Il tratto di paramento contrassegnato con …. potrebbe rivelarsi la ricercata struttura muraria di recinzione lungo questo tratto della cittadella, ma per poterlo affermare in maniera certa occorrerebbe rimuovere le strutture sovrastanti.
Non restava pertanto che programmare un’ulteriore allargamento del saggio in direzione NW fino ad almeno raggiungere il tratto di muro del periodo Viola meglio conservato (fino a quattro filari sovrapposti) per accertarne la cronologia e soprattutto verificarne la possibile sovrapposizione con le cinte murarie precedenti.
H/ovest 1997
Il saggio H/ovest 1997 costituisce l’ampliamento verso N delle due grandi trincee di scavo aperte rispettivamente nel 1993 e nel 1995 e il raccordo con i saggi Z ed H/est (Tav. IV).
L’ampliamento di questo saggio verso N è stato dettato in primo luogo dalla necessità di raccordare i quadrati meridionali, indagati nel 1995, con l’area direttamente a N di essi, mai esplorata in passato, nel tentativo di individuare il proseguimento del grande muro del periodo Bruno.
Una tale possibilità, tra l’altro, sembrava suggerita dall’affioramento di un lungo tratto di muro, in qualche punto conservato per quattro filari, lungo l’estremità settentrionale della collina nell’area compresa tra le due grandi trincee di scavo aperte da Arias nel 1931 [5]. In questa prospettiva risultava di estremo interesse accertare la natura e la cronologia di questa struttura, indicata da Bernabò Brea – in accordo con Della Seta – come un muro di terrazzamento agricolo forse di epoca medievale [6]. D’altra parte, I’interesse per la datazione della struttura non poteva andare disgiunto dall’evidenza offerta da una radicale pulizia del muro, effettuata dallo scrivente nel settembre del 1994 in occasione dei lavori per il progetto “Egeo”, che aveva restituito un cospicuo gruppo di frammenti ceramici del Bronzo Tardo, tra cui due frammenti micenei del T E II-
La terza motivazione che giustificava l’ampliamento del saggio verso l’estremità settentrionale della collina risultava connessa con la necessità di chiarire la natura e la funzione di alcuni muri, anche di notevole spessore, messi in luce al di sotto del muraglione del periodo Bruno. La possibile datazione di essi nel periodo Verde lasciava sospettare una possibile relazione con le case della medesima fase indagate poco più a S nel saggio H/ovest 1993, facendo pensare ad una estensione dell’abitato anche più a N, in un’area che i primi scavatori avevano considerato esterna alla città.
L’indagine ha interessato due distinti settori, che abbiamo indicato per semplicità come “Nord” e “Sud”.
Settore Nord
Il primo settore di indagine, che occupa i quadrati 4-8111-14 (superficie 65 mq ca.), è ubicato in prossimità del ciglio della scarpata, esattamente a 6 m dal limite settentrionale del saggio H/ovest 1995. Quest’area risultava interessata da un forte ingombro di pietrame e terra di riporto proveniente dai saggi degli anni 1930-36 e l951-56. Inoltre, in qualche punto affioravano dello strato superficiale alcune strutture murarie, non riportate nella palnimetria generale di Bernabò Brea.
Rimosso lo scarico dei vecchi scavi, direttamente al di sotto dello strato US 1 e caratterizzato da terriccio incoerente con pietre ricco di frammenti riferibili ai periodi Verde, Rosso e Giallo, è stato messo in luce in tutta l’area un deposito di pietrame (US 2), con particolare addensamento nell’estremità settentrionale del saggio. La rimozione di questo strato, nel quale si sono raccolti frammenti in prevalenza attribuibili al periodo Rosso, ha consentito di mettere in luce nella parte del saggio, in corrispondenza del ciglio della scarpata, una struttura costituita da due allineamenti di grossi massi, entro cui era contenuto pietrame informe (struttura A). Questo muro, che si perdeva a S sotto i limiti della trincea, verso settentrione si raccordava con un secondo allineamento EW, parallelo al ciglio della collina, obliterato da uno spesso deposito di pietre di grandi dimensioni.
Questa seconda struttura rappresentava il lato meridionale di una ‘torre’ di forma quadrangolare (4,5 m NS x 3,8 m EW), conservata per cinque filari sovrapposti, la cui faccia settentrionale era costituita dall’allineamento di pietre lasciato in situ da Arias nel 1931 a ridosso della sua trincea occidentale. La cd. torre (struttura B), che presentava le fondazioni costruite con grossi blocchi informi su cui si elevava l’alzato con pietre di minori dimensioni, risultava impostata direttamente su un imponente deposito (US 6) di terreno cineritizio, intervallato da lenti di argilla e terriccio incoerente, ricco di ossa di animali, di conchiglie e di frammenti ceramici riferibili esclusivamente al periodo Azzurro evoluto. Le caratteristiche compositive e stratigrafico-deposizionali di questo strato lasciano supporre che esso sia un lembo superstite della “grande discarica Nord” scavata da Arias nel 1931.
Verso E, la cd. torre presentava due prolungamenti della struttura che si attestavano in corrispondenza del limite della trincea orientale degli scavi Arias. Questi muri, costituiti da pietre e da lastre poste per taglio in maniera assai accurata, delimitavano un ambiente di circa 2,30 m. di larghezza (struttura C), che nella parte superstite, a ridosso del testimone, risultava colmo di sabbia e terreno argilloso di colore giallastro con tracce di cenere e qualche frammento ceramico attribuibile al periodo Azzurro (US S).
È molto probabile che l’intero complesso costituisca – in analogia con le strutture messe in luce nel vicino saggio H/est – un imponente sistema di contenimento della collina, formato da avancorpi quadrangolari, riempiti di terra e pietrame, che delimitavano ampi cassoni ricolmi di terriccio argilloso e di sabbia. Un piccolo saggio nell’emplecton della c.d. torre ha consentito di stabilire che la struttura sia effettivamente attribuibile al periodo Verde.
Le connessioni strutturali dell’avancorpo con il cassone posto direttamente ad E di esso lasciano supporre che si tratti di un unico impianto architettonico, riferibile con probabilità alla medesima fase costruttiva. Inoltre, risulterebbe assai verosimile che il sistema di muri, messo in luce da Arias nel tratto meridionale del suo scavo ed oggi non più conservato, sia in relazione con quest’opera di contenimento, come dimostrerebbe anche la documentazione fotografica del 1931 nella quale si vedono alcuni allineamenti paralleli impostati direttamente sulla discarica del periodo Azzurro.
Un saggio di controllo all’estremità meridionale del torrione ha consentito di stabilire che il grande allineamento a doppia cortina risulterebbe posteriore alla costruzione dell’avancorpo dal momento che esso sembra addossarsi contro la facciata della cd. torre. Inoltre, la fondazione del grande muraglione risulterebbe alla stessa quota di un allineamento parallelo alla faccia originaria settentrionale della cd. torre, lasciando sospettare che in una fase posteriore all’impianto dell’avancorpo sia stato costruito il grande muro con un possibile arretramento del prospetto settentrionale.
Questo rifacimento andrebbe collocato con molta probabilità nell’ambito del periodo Rosso, come suggeriscono i frammenti ceramici raccolti nell’emplecton e nella trincea di fondazione della struttura a doppia cortina.
Nell’area orientale dello scavo, compresa tra il muro, la cd. torre e il relativo cassone a N, sono state messe in luce alcune strutture abitative, delle quali però la relativa estensione del saggio non ha consentito di chiarire le relazioni planimetriche. L’ultimo strato di vita delle case, costruite a ridosso dell’opera di contenimento (US 3) ha restituito materiali del periodo Rosso, mentre un piccolo saggio di approfondimento nei quadrati 4/13-5/13, ha consentito di mettere in luce, al di sotto del piano pavimentale del periodo Rosso, un breve tratto di muretto curvilineo, conservato per due filari e i resti di un piano pavimentale (US 4), ipoteticamente assegnabili al periodo Verde.
Riepilogando, I’esame delle strutture messe in luce dal saggio H/ovest 1997 consente di delineare la seguente successione stratigrafica ed architettonica.
- Il primo episodio costruttivo del muro, inquadrabile nel periodo Verde, è rappresentato dall’imposta della cd. torre B con relativo cassone C, da mettere in rapporto all’esistenza di un sistema di contenimento e di contraffortamento della terrazza su cui erano costruite alcune case. Essi si impostano direttamente sulla grande discarica che era stata indagata da Arias negli anni ’30.
- La costruzione, nel corso del periodo Rosso, del grande muraglione A, che lascia intravedere un possibile restringimento dell’abitato verso E. Assai significativa risulta, in tal senso, I’assenza di abitazioni nell’area direttamente a W del muro A, nella quale è stato trovato soltanto un imponente ingombro di terriccio giallo, forse riferibile al disfacimento di mattoni che costituivano l’alzato di tale muro. Il piano di imposta della struttura A direttamente alla stessa quota delle fondazioni delle case a ridosso di essa, la tecnica di costruzione a doppio paramento, il notevole spessore e il tipo di alzato in mattoni, lasciano sospettare che si tratti di una struttura a carattere difensivo.
- Significativa assenza di strutture riferibili al periodo Giallo, a conferma di quanto già rilevato nel saggio del 1995, lasciando intuire che in questa fase il limite settentrionale dell’abitato non superasse l’area del megaron 317.
Settore Sud
Il settore Sud di H/ovest 1997 è stato aperto allo scopo di seguire il prolungamento del grande muro A e accertare se esso fosse in qualche modo in relazione con la struttura difensiva del periodo Bruno indagata nel 1995. Dopo aver lasciato un breve passaggio di circa 3,5 m è stato aperto un quadrato in direzione dell’allineamento della struttura A, che è stata profilata a pochi centimetri al di sotto del paino di campagna. Esplorato ancora per circa 4,3 m, il muro si arrestava in corrispondenza di un ampio scasso nel terreno di natura agricola. Le forti manomissioni del deposito e l’accentuata pendenza degli strati assai erosi non hanno consentito di indagare il prolungamento del muro A verso S, anche se la presenza di tre grandi massi allineati forse ancora in situ lascia sospettare che il muro piegasse verso SW, in direzione di un enorme ammasso di pietrame che potrebbe rappresentare parte dell’emplecton.
Anche in questo settore, nella fascia direttamente ad E del presunto allineamento, sono stati messi in luce i resti di alcuni ambienti a pianta quadrangolare costituiti parallelamente al tratto occidentale della Strada 108b, scavata nel 1931 da Pietrogrande [7]. I pochi materiali recuperati sul suolo di questi ambienti si riferiscono omogeneamente al periodo Rosso.
È molto probabile che queste case abbiano avuto diverse fasi costruttive e non andrebbe escluso che almeno in un caso (quadrato 1-12), le più tarde case rosse siano state edificate direttamente al di sopra di una struttura del periodo Verde, segnalata dalla caratteristica tecnica costruttiva di lastre disposte per taglio.
In quest’area lo scavo si è arrestato alla rimozione dello strato di pietrame che obliterava le case del periodo Rosso, lasciando una parte di esso in corrispondenza del trattooccidentale, a ridosso dello scavo del 1995.
Alla fine della campagna di scavo si è proceduto al consolidamento della struttura A e della torre B, in particolar modo nel tratto sud-occidentale dello scavo dove le ripetute erosioni del terreno avevano asportato alcuni blocchi della fondazione.
Massimo Cultraro
Note
[1] Il presente testo è l’esito di una revisione redazionale delle relazioni delle singole campagne di scavo del saggio H/ovest elaborate da M. Cultraro.
[2] Poliochni I, 243 ss.
[3] Tra i materiali si segnalano due frammenti di ceramica a vernice nera tipo Urfirnis greco continentale pertinenti ad una salsiera.
[4] Poliochni I, 649-650.
[5] Poliochni I, 255 ss.
[6] Poliochni I, 000-000.
[7] Poliochni I, 243-245.
